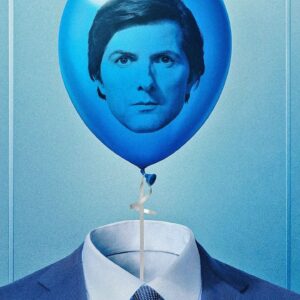Vitalina Varela: recensione del film vincitore del Pardo d’oro a Locarno 72
Le nostre opinioni sul film di Pedro Costa
Il Concorso Internazionale del Festival di Locarno 72 ha visto primeggiare la nuova opera scritta e diretta dal cineasta portoghese Pedro Costa. Il regista di Lisbona ritorna in terra elvetica dopo il successo di Cavallo Denaro del 2014 (Pardo d’Argento per la miglior regia a Locarno 67), e si aggiudica il Pardo d’oro. All’attrice Vitalina Varela, di cui il film porta significativamente il nome, il Pardo per la miglior interpretazione femminile; come per Cavallo Denaro, assieme al regista firma anche la sceneggiatura. Qui la nostra recensione di Vitalina Varela.
Costa costruisce un ideale dittico proponendo una sorta di successore spirituale, rimanendo fedele alla sua visione cinematografica. Collegando le due metà grazie a Vitalina Varela, introdotta nel film precedente come parente di Ventura, egli riesce a costruire uno squisito passaggio dialettico fra le sue pellicole. Magistralmente le storie si rinnovano ma concetti e visione rimangono solidi, come se fossero radici dello stesso tronco, confezionando un’opera profonda, struggente ma al contempo ostica.
Indice
Vitalina Varela recensione – Trama

Vitalina Varela è una donna di cinquantacinque anni, forte e decisa, originaria di Capoverde e maritata a Joaquim de Brito Varela. Costui la abbandonò alla loro dimora a Capoverde ed emigrò a Lisbona, nel quartiere povero di Fontainhas; da allora, solo due furono i contatti fra la coppia. Dopo aver atteso per più di venticinque anni il biglietto aereo per Lisbona, Vitalina sbarca in Portogallo richiamata dalle precarie condizioni di salute del marito. Sui volti sconsolati dei conoscenti che la attendono comprende che il tempo l’ha tradita ancora: è in ritardo di soli tre giorni, il marito è già morto. Bastano tre giorni per sgretolare venticinque anni di attesa, resistenza, fatiche, domande.
Inizia con quella discesa dall’aereo la catabasi di Vitalina verso un mondo oscuro, sporco e fatiscente, come la casa dove viveva Joaquim e in cui lei è adesso costretta a dimorare. Attorno uomini e donne fiaccati, magri e poveri. Un prete predica fra le disabitate strettoie in pietra, prova a mantenere ancora salda la comunità cercando di risollevare una coscienza religiosa oramai spenta, ma è anche lui preda del tempo e della disillusione. Un racconto sofferto e piacevolmente didascalico che urla la propria rabbia e non fa sconti allo spettatore, trasportandolo in una dimensione dilatata determinata da tempi lunghi e incredibile cura visiva.
Abitare per essere

Nella riflessione socio-politica di Pedro Costa e di Vitalina Varela, la dimora diventa l’elemento cardine di un sistema di svelamento progressivo dell’anima. Il concetto di ricerca di una casa, di un rifugio, è comune a tutti gli uomini ed è inteso come azione naturale, eppure al giorno d’oggi viene pensato in termini tanto meccanici quanto semplicistici (in particolare da popoli fortunati che possono facilmente permettersene una). Quattro mura in pietra, invece, trascendono la semplice solidità materica e si fanno simulacro e compendio di desideri, ricordi e passioni di chi la compra o costruisce. È un simbolo di appartenenza a cui siamo intimamente connessi e in cui ci riflettiamo, e alle sue sorti siamo indissolubilmente legati.
La casa del marito di Vitalina, fatiscente rudere prossimo al crollo, diventa quindi metafora della vita e del passato della donna. I ricordi fluiscono e si concretizzano magistralmente attraverso lunghi e placidi monologhi e dialoghi immersi nel buio della natura e dell’esistenza, giungendo a prendere conturbanti connotati come di una seduta spiritica. L’abitazione costruita col sudore a Capoverde è oramai abbandonata, quella a Lisbona cade a pezzi: così è stato il rapporto fra moglie e marito. Allo stesso modo la cappella, fredda e vuota, dimostra come non possa esserci una Casa di Dio senza che siano uomini felici e in comunione ad illuminarla. Rimane però una possibilità, un appiglio grazie al quale iniziare una risalita che possa portare l’uomo a riappropriarsi di se stessi e della propria dimora.
Chiaroscuro

Ciò che colpisce della pellicola vincitrice del Festival di Locarno 72 è l’incredibile rigore estetico a cui Pedro Costa sottopone riflessioni, ambienti e spettatori. Questo quartiere, intricato in un dedalo diroccato di strette vie e gallerie, ha l’oscurità come elemento ad esso connaturato. Non c’è quasi mai illuminazione, non c’è guida, non c’è, forse apparentemente, speranza: qualunque elemento di luce tenti di sfuggire a questa regola, viene strozzato. Addirittura, accendere una candela può essere un peccato e venire punito dal destino in maniera nefasta. L’inferno e il dolore non sono lingue fiammeggianti o fiumi di lava, bensì un’oscurità glaciale che inghiotte il cuore. Le tenebre esistono, opprimenti, eppure il cineasta portoghese lascia una sottile possibilità di salvezza anche per chi parrebbe aver perso tutto. Sant’Agostino direbbe che l’ombra è un elemento necessario per far risaltare la luce.
Grazie alla bravura del suo storico direttore della fotografia, Leonardo Simões, Costa riesce a costruire un’atmosfera perfetta, greve e impegnativa. Costruisce un dramma che sembra un horror dell’animo, che si muove nel reale ma lo suggestiona con presenze opprimenti, cadaveriche, spirituali. Non stupisce dunque sapere che Costa, all’inizio degli anni novanta, progettava, anche se senza esiti, di dirigere un remake del cult del 1943 Ho camminato con uno zombi di Jacques Tourner (Il Bacio della pantera, L’uomo leopardo), maestro della fusione dell’ordinario e del chimerico al servizio dell’orrorifico. Un grande lavoro tecnico che permette di governare ogni spiraglio luminoso col quale rendere malleabili contorni, figure, architetture, scolpendo le mani e i volti.
Conclusione – Vitalina Varela recensione

La vittoria non stupisce e, alla fine della nostra recensione di Vitalina Varela, apre ad una importante riflessione su Locarno 72 . Nonostante la consegna di testimone dall’uscente direttore artistico Carlo Chatrian alla brava Lili Hinstin, non è stata un’edizione di transizione bensì la conferma dello spirito che distingue il festival svizzero. Si è puntato particolarmente sul ruolo della donna. A partire da documentari sulla prostituzione (Lovemobil), sullo sfruttamento delle domestiche filippine all’estero (Overseas), sulla denuncia di gravidanze minorili (Flapping in the Middle of Nowhere) e abusi sessuali (Instinct) fino alle eroiche gesta di una reporter di guerra (Camille). La pellicola portoghese non è solo un grande film, ma anche la concretizzazione del forte messaggio che ha pervaso molte delle opere presentate.
Quello di Pedro Costa si conferma un cinema lento, dilatato, intenso, ma anche arduo. Non è possibile che sia amato da tutti, per sua natura, ma se riesce ad avvolgere nel suo abbraccio folgora e non lascia impassibili. Rimane dentro, tanto nei temi quanto nelle immagini, ed è impossibile scrollarselo di dosso. Un film del genere trapassa lo schermo e rende la stessa visione un’esperienza intensa e dalle numerose sfaccettature. Rimane la possibilità di esserne scottati, annoiati, o infastiditi da un impianto visivo tanto pretenzioso quanto radicale: ma il tentativo va fatto.
Voto - 8
8
Lati positivi
- Dramma forte e profondo
- Grande interpretazione
- Sorprendente rigore estetico
Lati negativi
- Visione assai impegnativa